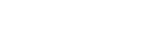Fonte www.grusol.it - Vorrei riprendere e approfondire alcuni dei contenuti della tua intervista, in www.lombardiasociale.it, Sanitarizzazione la responsabilita è anche nei servizi?. Lo faccio non solo e non tanto per la condivisione di ciò che dici, ma perché mi sembra che descrivi una situazione che moltissimi territori si trovano a vivere. Una situazione che produce al tempo stesso sofferenza e rischia di generare impotenza in chi quei servizi li ha immaginati, pensati, aiutati a realizzarsi. La citazione è lunga ma credo sia utile. Tu dici “i servizi per la disabilità sono nati come proposte territoriali de-istituzionalizzanti ed oggi rischiano di essere soffocati da modelli organizzativi che ri-alimentano spinte re-istituzionalizzanti. I servizi per la disabilità sono stati concepiti per sostenere le famiglie a fronteggiare la convivenza con le disabilità più o meno complesse e si sono organizzati per sostenere le persone con disabilità a stare dentro la comunità. Servizi nati per accogliere le persone in strutture pensate per contrastare l’isolamento e l’esclusione sociale del vivere relegati in casa, per spezzare la simbiosi con le mamme ma anche la negazione totale dell’identità tipica dell’istituto. Servizi nati per sostenere percorsi di rafforzamento identitari della persona con disabilità. Servizi quindi concepiti e strutturatisi con una mission ed un’impronta educativa, psico-sociale che cercava di affermarsi come intervento professionale su base psico-pedagogica. Servizi che hanno aiutato le famiglie a tenere i figli a casa senza essere costretti ad istituzionalizzarli ed aiutato i figli a non vivere isolati, frequentando laboratori sociali che hanno inventato un modo nuovo per le comunità di porsi di fronte alla disabilità, tenendola dentro il perimetro comunitario. Tali servizi tuttavia, oggi appaiono in affanno a tener viva la propulsione ideativa a costruire nuovi mondi vitali dentro la comunità per favorire il benessere delle persone, tipica della loro prima stagione. Perché sono ridotti ed appiattiti su logiche di appropriatezza con-fuse in quanto prive di riferimenti scientifici, per nulla orientate a valutare gli esiti degli interventi, ed in molti casi mutuate da comparti organizzativi e gestionali per nulla omogenei al lavoro con la disabilità (perlopiù da ospedali e case di riposo)”. L’impressione è che di fronte a questo dato di realtà ci sia, soprattutto all’interno dei servizi, scarsa consapevolezza di una situazione che rischia di riportarci indietro con approcci e modelli che ritornano alla prestazione e si allontanano dalla prospettiva della qualità di vita.
Fonte www.grusol.it - Vorrei riprendere e approfondire alcuni dei contenuti della tua intervista, in www.lombardiasociale.it, Sanitarizzazione la responsabilita è anche nei servizi?. Lo faccio non solo e non tanto per la condivisione di ciò che dici, ma perché mi sembra che descrivi una situazione che moltissimi territori si trovano a vivere. Una situazione che produce al tempo stesso sofferenza e rischia di generare impotenza in chi quei servizi li ha immaginati, pensati, aiutati a realizzarsi. La citazione è lunga ma credo sia utile. Tu dici “i servizi per la disabilità sono nati come proposte territoriali de-istituzionalizzanti ed oggi rischiano di essere soffocati da modelli organizzativi che ri-alimentano spinte re-istituzionalizzanti. I servizi per la disabilità sono stati concepiti per sostenere le famiglie a fronteggiare la convivenza con le disabilità più o meno complesse e si sono organizzati per sostenere le persone con disabilità a stare dentro la comunità. Servizi nati per accogliere le persone in strutture pensate per contrastare l’isolamento e l’esclusione sociale del vivere relegati in casa, per spezzare la simbiosi con le mamme ma anche la negazione totale dell’identità tipica dell’istituto. Servizi nati per sostenere percorsi di rafforzamento identitari della persona con disabilità. Servizi quindi concepiti e strutturatisi con una mission ed un’impronta educativa, psico-sociale che cercava di affermarsi come intervento professionale su base psico-pedagogica. Servizi che hanno aiutato le famiglie a tenere i figli a casa senza essere costretti ad istituzionalizzarli ed aiutato i figli a non vivere isolati, frequentando laboratori sociali che hanno inventato un modo nuovo per le comunità di porsi di fronte alla disabilità, tenendola dentro il perimetro comunitario. Tali servizi tuttavia, oggi appaiono in affanno a tener viva la propulsione ideativa a costruire nuovi mondi vitali dentro la comunità per favorire il benessere delle persone, tipica della loro prima stagione. Perché sono ridotti ed appiattiti su logiche di appropriatezza con-fuse in quanto prive di riferimenti scientifici, per nulla orientate a valutare gli esiti degli interventi, ed in molti casi mutuate da comparti organizzativi e gestionali per nulla omogenei al lavoro con la disabilità (perlopiù da ospedali e case di riposo)”. L’impressione è che di fronte a questo dato di realtà ci sia, soprattutto all’interno dei servizi, scarsa consapevolezza di una situazione che rischia di riportarci indietro con approcci e modelli che ritornano alla prestazione e si allontanano dalla prospettiva della qualità di vita.
Condivido molto l’immagine dell’elastico che “ci tira indietro” verso approcci prestazionali e credo si tratti eminentemente di un problema di cultura e di pratica organizzativa. E mi spiego. Molti servizi sono stati anche incubatori di organizzazioni. Molte associazioni e molte cooperative sono nate dai servizi concepiti per sostenere persone e famiglie. Poi con il passare del tempo il consolidamento di questi servizi, in alcuni casi anche il loro sviluppo, il loro farsi più grandi, con maggiori responsabilità, con accordi pubblici, con ingenti risorse da amministrare, ha dovuto tener conto delle logiche delle organizzazioni che si sono strutturate per tenerli in piedi. E nella maggior parte dei casi le organizzazioni, anche quelle piccole, hanno optato per la via più facile: industrializzare la produzione dei servizi sulla base degli standard normativi istituzionali via via emanati dalle singole Regioni. Hanno industrializzato l’unità produttiva di base del servizio, l’intervento diretto alla persona, ri-ducendolo a prestazione standardizzabile e replicabile. E questo è avvenuto fisiologicamente perché le organizzazioni nel lungo periodo funzionano così. Tendono a minimizzare costi e fatiche spingendo, per così dire, verso il basso gli sforzi di contenimento della pressione esogena che devono affrontare quotidianamente. Agiscono, in primis, in chiave difensiva. Proteggono i confini, irrobustiscono le mura. Non è solo o tanto un problema culturale, ideologico, di interessi più o meno manifesti da perseguire. È un fatto quasi naturale tipico delle organizzazioni. Quindi, nel percorso di crescita dei servizi è successo che da un lato le Regioni a fronte di crescenti domande e di crescenti investimenti hanno dovuto incrementare finanziamenti e regole. E le organizzazioni nate dai servizi hanno semplicemente finito per dover rispettare le regole imposte dalle istituzioni. Istituzionalizzando il loro agire organizzato. Personalmente ritengo che oggi i tempi siano maturi per ripensare il sistema dei servizi attraverso una riconversione di questo processo di industrializzazione. Che non significa tornare allo stato nascente della spontaneità organizzativa priva di regole. Esattamente il contrario. Significa industrializzare le organizzazioni, farle crescere sul piano culturale per consentir loro di sviluppare gli anticorpi necessari a non ridursi fisiologicamente ai minimi termini e quindi a ri-produrre logiche istituzionalizzanti che mortificano le prestazioni. Significa portare un po’ di pressione del confronto con il mondo esterno dai “confini organizzativi” verso le zone di comando delle organizzazioni, per aprirle a nuovi scenari di confronto, a nuove mete e forse ad un vero e proprio ripensamento delle stesse ragioni per cui sono nate. L’obiettivo dev’essere quello di aiutare le organizzazioni a tutelare e valorizzare le prestazioni da cui sono nate, man-tenendo o riscoprendo il livello di umanità, di libertà di pensiero e di freschezza di quando sono nate. Il problema non è l’atto della prestazione in quanto azione finalizzata. E’ ciò da cui essa muove, come si compie e il risultato che produce. Se noi prevediamo norme regolative dei servizi in cui basta che ci siano delle prestazioni classificabili e codificabili e rintracciabili e diamo per scontato (e quindi non apprezzabile e valutabile) ciò che viene prima (la motiv-azione), il suo compiersi (inter-azione) e il suo esito, mandiamo in corto circuito la relazione di aiuto che è sempre un atto bilaterale e mai unilaterale. Mortifichiamo l’esperienza (da ex-perientia = stare dentro la vita) del suo compiersi privandole del senso e del significato che matura nella relazione. Bisogna invece che gli operatori dei servizi tornino ad essere liberi di inventare e di re-inventarsi oltre i perimetri delle norme; riformulando i significati del loro agire e ri-valutando esiti e risultati in funzione del senso che le persone, gli operatori e la comunità riusciranno ad attribuire ai prodotti ed alle prestazioni di questi interventi. E’ un’operazione di “sottrazione di peso” (rubando le parole a Calvino) che serve ai servizi per tornare ad essere luoghi caldi pieni di umanità con attenzioni e interventi che siano insieme su misura per la persona e in qualche modo ri-generatori di comunità e generatori di benessere. La parola d’ordine delle organizzazioni dovrebbe diventare, oltre gli standard, verso nuove mete e nuovi risultati alla ricerca del benessere delle persone fragili e di ci le sostiene. La chiave di questa trasformazione è lo spostamento dell’investimento “industrializzante”, dalla prestazione di base del servizio, la relazione d’aiuto, alla sua “costituzione” organizzativa. Se fosse un organismo umano potremmo dire che non basta “corazzare” la pelle ma occorre far funzionare bene la circolazione del sangue nel nostro corpo. Solo alzando il loro livello di competenza progettuale, di studio, di ricerca, di valutazione degli esiti e degli impatti sociali, le organizzazioni potranno ritrovare all’interno del loro agire la spinta necessaria per cambiare un po’ il mondo in cui operano (in quanto, assunto di base ogni organizzazione è costitutivamente quello di cambiare le cose nel mondo in cui opera). E quindi questo significa che le organizzazioni devono trovare risorse da immettere non solo sulla prima linea ma anche a supporto di chi sostiene le prime linee. Le organizzazioni sociali devono quindi promuovere studi sulla comunità, sugli esiti dei loro interventi, sul benessere che realizzano, attraverso partnership qualificate. E se tali attività non sono remunerate ed i servizi non generano margini sufficienti per sostenerle, le organizzazioni dovranno allearsi tra loro e generare questi studi e queste attività di ricerca facendoli insieme, alleandosi, collaborando, condividendo energie e risorse. E dovranno farlo cambiando il loro modo di organizzarsi. Comprando insieme energia elettrica tra diverse organizzazioni si possono risparmiare soldi da investire in formazione. Condividendo lo psicologo o il direttore amministrativo tra diverse piccole organizzazioni che operano tutte nel raggio di 40 km si può far crescere il livello organizzativo di diverse realtà con-dividendo i costi invece di lasciare alcune realtà molto avanti ed altre realtà molto indietro.
Nella parte finale del tuo scritto riprendi la questione del “mandato professionale degli educatori”, introduci la questione dei percorsi formativi e li inviti a pensarsi come “operatori sociali militanti, impegnati a ri-progettare i contesti di vita delle comunità, per promuovere il benessere delle persone”. Mi sembra che se da un lato ci sia un problema di “rivitalizzazione” o meglio di “coscientizzazione” degli operatori, dall’altro ciò che si respira all’interno di molti soggetti gestori, in particolare, ma non solo, quelli meno legati ai territori è una scarsissima progettualità e la volontà, se il servizio è in affidamento, di allentare ogni minimo conflitto con i “committenti”.
La militanza dell’operatore sociale è condizione necessaria ma non sufficiente. L’operatore sociale a cui non frega niente di come va il mondo e di come sta il prossimo suo è fuori posto. L’educatore e l’operatore sociale non possono agire senza inserire il loro mandato all’interno di un orizzonte di senso più ampio (come sta e come funziona la persona nell’ambiente in cui vive e come questo ambiente favorisce il benessere della persona e come la comunità vede, riconosce, percepisce, prende parte ai percorsi trasformativi necessari ad abbassare il tasso di esclusione e di malessere dei suoi abitanti). Ma questo interesse non deve essere per forza solo valoriale, morale o ideale. Il giacimento di questo interesse non deve stare solo dentro l’operatore. Anche l’organizzazione in quanto tale deve assumere come prioritario il compito di alimentare, sostenere e tenere in vita questo orizzonte di senso. Non può ridursi a contare solo sulla “militanza” dell’operatore, altrimenti lo manda “fuori giri, fuori squadra”. Per questo sostengo sopra la necessità che le organizzazioni tornino a pensare e ritengo che debbano essere spesi soldi anche per pensare e sperimentare. Proprio perché siamo pieni di contingenze in cui ci troviamo di fronte a dilemmi apparentemente non risolvibili: tipo aumentare gli interventi per le persone con disabilità in assenza di risorse aggiuntive o addirittura in presenza di contrazioni di risorse.
L'intervista integrale è disponibile a questo link