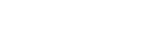Una riflessione e
testimonianza sul diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità
Una riflessione e
testimonianza sul diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità
Articolo tratto dalla rivista "Oltre" di Anffas Onlus Milano (n. 3-4 2010), a cura di Angelo Fasani*:
Le persone con disabilità abbiano la possibilità di
scegliere,
su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di
residenza e dove e con chi vivere
e non siano obbligate a vivere in una
particolare sistemazione.
(Dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità, art. 19 )
Nel maggio 2010, tre operatori LEDHA, Giovanni Merlo, Guido
De Vecchi e Paolo Aliata, avviarono una riflessione con un intervento dal titolo
"RSD: un servizio da ripensare?". La riflessione ha suscitato parecchi
interventi da parte di altre persone che si occupano di disabiltà (v. www.personecondisabilita.it
"Archivio opinioni"). Carla torselli, Presidente di Anffas Lombardia, nel suo
intervento aveva posto in evidenza alcune domande sul tema tra le quali la
seguente: «È vero che questi servizi, per loro "natura", non possono essere
luoghi dove i diritti umani delle persone con disabilità possono essere
promossi, protetti e garantiti? La risposta di una operatrice, Anna, potrebbe
confermare che è così. Però tutte le altre risposte, pur riconoscendo le
difficoltà insite nella cura di persone in genere molto compromesse per il loro
stato di non autosufficienza e/o di facoltà intellettive e relazionali fragili,
sostengono che ci sono possibilità di sperimentare modelli diversi e più
positivi, in grado di offrire abitabilità a chi vive una grave condizione di non
autosufficienza e di disagio cognitivo e relazionale».
La testimonianza di Anna
«Dopo diversi anni di
lavoro all'interno di strutture socio-sanitarie a contatto con persone con
disabilità intellettiva e fisica, mi trovo oggi a fronteggiare una terribile
situazione nella RSD in cui lavoro. La vita è scandita da ritmi severi e
standardizzati che opprimono le libertà individuali. Dopo la sveglia, ogni
persona viene lavata, vestita, e portata nella sala della colazione. Spesso gli
operatori svolgono queste azioni ignorando totalmente le persone verso le quali
sono rivolte. Le esigenze personali di ciascuno passano in secondo piano
rispetto alla routine. Alcune mattine capita che gli operatori chiacchierino fra
di loro a voce alta, a volte urlano, noncuranti delle persone che stanno
assistendo. Spesso litigano, oppure ascoltano la musica. La colazione dura due
ore, durante le quali non è permesso alzarsi troppe volte dal tavolo,
allontanarsi dalla sala o chiedere continuamente un bicchiere d'acqua o di
andare al bagno. Le conversazioni tra operatori continuano a voci sempre più
alte e si stizziscono se vengono interrotte da chi vuole un'altra tazza di the o
un altro biscotto. Finita la colazione due operatori accompagnano la maggior
parte delle persone in un'unica stanza a guardare la tv. Poche volte si
organizzano giochi o attività di gruppo come previsto dal programma giornaliero.
Il pranzo è a mezzogiorno e dura mezz'ora. Poi riposo pomeridiano. Alle 15 e un
quarto si fa merenda. Ore 16 in punto di nuovo in sala tv a vedere un programma
che sceglie lo stesso operatore, non in base ad un protocollo o alle preferenze
dei pazienti, ma secondo il proprio gusto. Alle 18 si cena, categoricamente già
in pigiama e successivamente, con orario massimo per le 19 tutti a letto.
Durante la notte non è possibile chiedere di essere cambiato in un momento non
prestabilito o "non opportuno". Gli operatori si ostacolano tra di loro rendendo
la collaborazione scarsa o inesistente, la figura medica è spesso assente,
mentre il gruppo dirigenziale è impegnato a curare solamente l'immagine esterna
della struttura. Le persone presenti nella struttura vengono raggruppate
indipendentemente dalla fascia d'età, sesso o tipo di disabilità o disagio
psichico. Non si cerca di migliorare la loro qualità della vita attraverso
l'accoglienza, l'ascolto e la personalizzazione degli ambienti. Le famiglie
spesso stanche, in cerca di un appoggio si trovano di fronte all'incomprensione.
Vengono sgridati se assillano gli operatori con richieste di informazioni sullo
stato di salute del proprio parente. Tutto deve essere funzionale, sì, ma a un
ritmo di lavoro, a una prassi, a un protocollo».
L'impronta culturale
Marco Bollani, Direttore della
Cooperativa sociale Come noi di Mortasa, ha aperto il suo intervento con queste
parole: «Penso che l'impronta culturale che tu dai al servizio ne determina
l'identità, ben più che la normativa di riferimento che ne definisce gli
standard di funzionamento. Questa è la mia opinione, ma prima ancora è la mia
esperienza. Ma proprio in virtù della mia esperienza, rileggendola e cercando di
contestualizzarla nell'attualità di questi ultimi anni aggiungerei che sì, la
RSD è davvero un servizio da ripensare, e prima lo si fa meglio è. Ripensarlo
però non vuol dire "rottamarlo", metterlo al bando, negarne la necessità,
l'utilità. Semmai il contrario».
Michele Imperiali (D.G. Fondazione R. Piatti Onlus di Varese), nel suo intervento aveva, tra l'altro detto: «Sono fermamente convinto che l'umanizzazione delle RSD (spazi, attività, relazioni, ecc.) dipenda dalla visione del gestore e dalla sua capacità di cogliere i margini di manovra che le regole comunque consentono. Uno su tutti la possibilità di migliorare gli standard di qualità (personale, attività, specialisti ecc.). Le RSD diventano un "non luogo" quando i gestori le fanno diventare così».
«Nella mia esperienza di direttore di una cooperativa sociale Anffas – sono ancora parole di Marco Bollani – , nel corso di questi anni ho potuto apprezzare lo sforzo e la fatica di molte persone con disabilità, di molti operatori, genitori e volontari, nel mantenere viva la sensazione di sentirsi a casa propria. E non poteva essere altrimenti. La nostra struttura (ove ha sede la RSD) è nata per questo. È una palazzina, costruita dai genitori dell'Anffas, per quando loro non ci saranno più e i loro figli avranno bisogno di una casa e di un ambiente in cui vivere, nel miglior modo possibile.
Quando è stata costruita la struttura, i familiari dell'Anffas e i soci della cooperativa che li hanno aiutati, non avevano in mente il piano socio assistenziale dell'89 che disciplinava gli standard strutturali del CRH. Avevano in mente un ambiente vicino a casa, in città, che potesse essere spazioso, confortevole e luminoso». E più avanti: «dal punto di vista pratico, molto pratico, molto concreto direi, è necessario ribadire che dietro qualsiasi idea di servizio, modello di riferimento, modello organizzativo, prescrizione normativa, c'è un idea precisa di uomo. E mi spiego. Se metto in piedi un servizio e lo destino a persone "non più assistibili a domicilio" e basta, e non dico più niente, la mia idea di uomo, di persona che devo accogliere lì dentro, è quella di una persona che viene lì per essere assistita, ben assistita (ci mancherebbe altro). Se però nella norma ci aggiungo anche quelle quattro righe in corsivo scritte sopra, vuol dire che chi viene accolto "lì dentro", "li dentro" deve viver-ci. E vivere bene. E che per vivere bene non basta che la struttura certifichi di "aver in dotazione un buon protocollo operativo per il corretto igiene del cavo orale" ... Bisogna che la struttura dimostri (che è un gradino più alto del "certificare") che chi vive lì si senta a casa sua. E che chi vive lì, viva anche il luogo in cui il servizio è ubicato. Significa che chi vive lì, vive in RSD, ma vive anche il quartiere della città, partecipa alla vita della città, viene ri-conosciuto come un qualcuno che abita e vive in quel quartiere lì, dove incontra persone, le vede, le sente, è visto, è sentito...Perché altrimenti, se sta sempre lì dentro e basta che vita fa? Una vita da cane, O no?».
Dignità e degnità della persona
Anche nelle parole
di Di Mario Mozzanica, docente del Dipartimento di Pedagogia dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che dato il suo importante contributo al
dibattito, ritorna al centro della riflessione la persona: «La residenzialità
"strutturata" (come lo è la RSD) chiede, a distanza di circa 7 anni dalla sua
istituzione (in Lombardia, n.d.r.), di provare ad interrogarsi su quale cultura
della disabilità abiti tale servizio. Abitare un sevizio chiede lo spazio di
riconoscimento della dignità e della degnità della persona con disabilità, cui
esso si rivolge. Lo scenario socioculturale postmoderno, al di là delle
affermazioni retoriche sui principi, stigmatizza spesso la disabilità,
collocandola nei differenziati ambiti: della diversità, della malattia, della
non autosufficienza, della mancanza, della classificazione diagnostica. Al
contrario, un'autentica antropologia riafferma, ineludibilmente, alcuni principi
fondamentali, cui ogni servizio/presidio dovrebbe riferirsi: la persona con
disabilità – persona unica e irripetibile – richiede non solo "cura" (cure), ma
competenza e attitudine alla capacità di "prendersi cura" (care), contrastando
ogni forma, che tende a requisire l'attenzione sociale nell'eccedenza della
medicalizzazione e della sanitarizzazione, sia nella cura, sia nella
riabilitazione, sia nell'assistenza; è indispensabile riconoscere alla
disabilità una competenza, che non è solo personale, bensì assume e riassume le
dimensioni di un vero e proprio "bilancio familiare", che sa accogliere la
fatica di un accompagnamento, che spesso esprime il volto di grandi virtù, nella
fedeltà e nell'affidamento, nell'accoglienza e nel dono di un figlio, soggetto
di riconoscenza, prima ancora che oggetto di assistenza; l'amore a un figlio con
disabilità rimane compiutamente, esemplarmente amore, degno di essere generato,
insegnato, consegnato e difeso; per questo occorre riaffermare la necessità,
l'urgenza e la priorità della tradizione e della traduzione di una prossimità
rispettosa e fraterna alla persona con disabilità, che pone al centro la persona
e il suo percorso esistenziale: dalla nascita, alla crescita, all'età adulta e a
quello snodo delicato, soprattutto per i genitori, del "dopo di noi", nelle
differenziate e possibili forme dell'abitare e del "risiedere"; in tale
prospettiva occorre riconoscere e riaffermare che la disabilità non è e non
significa mai solo bisogno; è soprattutto domanda.
È invocazione di aiuto, ma è anche provocazione agli stili di vita diffusi del mondo contemporaneo; non è solo mancanza o assenza, è soprattutto ventaglio di opportunità; è presenza, dai molti volti, che interpella e convoca forme, talvolta inedite, di prossimità. È questa la prospettiva entro la quale occorre ricollocare la "residenzialità" per la persona con disabilità: un luogo per abitare, per vivere (ben oltre tutte le omologazioni verso forme di normalità più o meno». Si potrebbe suggerire ad Anna di proporre alla riflessione dei suoi colleghi della RSD parole come queste e, più in generale, tutto ciò che è emerso da quando, nel maggio del 2010, Giovanni Guido e Paolo con il loro intervento diedero il via alla riflessione collettiva che ne è scaturita.
Partire dalle reali necessità di ogni persona
Concludiamo con il contributo dell'esperienza di Renzo Bagarolo,
Direttore Sanitario della RSD Piccolo Cottolengo Don Orione di Milano. «Ho
imparato in questi anni di confronto sui problemi della disabilità a riflettere
partendo dalle storie delle persone prima di avventurarmi nelle analisi dei
massimi sistemi, perché questo mi (ci) aiuta a non perdere mai di vista il senso
dei pensieri e delle azioni. Quindi inizio queste mie riflessioni con la storia
di F. un ragazzo di 32 anni accolto in RSD nel gennaio di quest'anno (2010). F.
è una persona tranquilla, espansiva, affettuosa, affetta da sindrome di Down,
che fino all'inserimento in RSD viveva a casa con la madre, aveva frequentato
con successo le scuole elementari e medie ed in seguito un Centro Diurno. Nel
2005 aveva interrotto la frequenza del centro per le difficoltà (riferite dalla
madre) nella gestione del diabete mellito e della celiachia di cui è affetto.
Negli ultimi anni ha vissuto con la madre in una situazione di "isolamento"
sociale e di "impoverimento" delle relazioni, tanto che il rapporto con la
stessa madre era divenuto conflittuale ed aveva spinto entrambi a pensare ad una
soluzione di "vita autonoma" fuori di casa. La soluzione individuata dalla madre
e accettata dal figlio è stata quella di un inserimento presso il nostro
servizio RSD. Dopo l'accoglienza ed un breve periodo di valutazione si è
riusciti a stabilizzare il diabete mellito ed ad organizzare una dieta
personalizzata per la celiachia, dove anche la madre è coinvolta nella
preparazione di alcuni piatti "speciali". F. è un ragazzo con molti interessi e
abilità che è riuscito a mantenere in buona parte in RSD, esce volentieri per
recarsi dalla madre ma vive gran parte della sue relazioni in residenza o
all'esterno durante lo svolgimento di attività significative (mercato, cinema,
oratorio, centro commerciale, ecc.). D. invece non ha scelto di venire in RSD, a
dicembre 2009 vi è stata trasferita dall'ospedale, poiché i genitori anziani
difficilmente sarebbero riusciti a "gestire" al domicilio i nuovi problemi
sanitari insorti dopo l'ultimo ricovero. D. è una ragazza di 39 anni affetta da
tetraparesi spastica progressiva, nonostante i problemi di salute ed i frequenti
ricoveri in ospedale, aveva frequentato fino al 2° anno di scuola superiore e
svolgeva un lavoro di "segreteria" fino a pochi anni fa, attualmente frequentava
un Centro Diurno (CDD). A ottobre 2009, ricoverata in rianimazione per una grave
insufficienza respiratoria le è stata praticata la tracheostomia e
"confezionata" la gastrostomia per l'alimentazione enterale, necessitava di
frequenti controlli clinici. Il percorso di inserimento in RSD è stato difficile
e complesso, l'instabilità clinica, i problemi sanitari e l'accettazione della
nuova condizione di vita hanno messo a dura prova D., i famigliari e l'equipe
della RSD. Oggi D. mangia senza necessità di stomia che le è stata rimossa, sta
facendo un percorso di recupero dell'espressione verbale ed un tentativo di
rimozione della tracheostomia, i problemi sanitari da gestire sono ancora
importanti (deve essere broncoaspirata più volte al giorno) ma compatibili con
la vita comunitaria e la partecipazione alle attività di laboratorio (esce al
mercato, ascolta musica, vede film, passa buona parte della giornata insieme ad
altre persone), ha ripreso un'accettabile vita di relazione. Queste sono solo le
più recenti delle molteplici storie delle persone accolte in RSD al Piccolo
Cottolengo Don Orione di Milano, un servizio residenziale di 72 posti letto,
organizzato in 4 nuclei (per noi 4 piccole comunità diffuse) differenziati per
bisogni omogenei ed in tal senso "standardizzati" per le cure ma non per la vita
di ciascuna delle persone accolte. Il mio giudizio sulle RSD, con l'esperienza
di questi anni da operatore e osservatore coinvolto, è critico ma non negativo.
Le criticità non sono le dimensioni o la "standardizzazione" (non ho mai creduto
che "piccolo" sia garanzia di qualità ma solo di miglior controllo) ma la
cultura ed i contenuti di un servizio insieme al percorso di scelta e di accesso
al servizio stesso. In termini tecnici tutto questo si definisce
"appropriatezza", che vuol dire la cosa giusta, alla persona giusta, al momento
giusto, questo vale per le persone con disabilità come per tutti noi quando
usufruiamo di qualunque servizio. Quando parlo di cultura e contenuto del
servizio a sostegno delle persone con disabilità intendo in particolare la
capacità degli operatori di farsi carico della "complessità" di cui è portatore
spesso la persona in condizione di disabilità, che significa problemi multipli,
contemporaneamente presenti e interattivi, così che le soluzioni non sono mai né
semplici, né "banali", e neppure possono essere rigide, definite a priori e/o
definitive. Tratto comune alle molte forme di disabilità è la coesistenza di
malattia, condizione esistenziale e svantaggio sociale che determinano
specificità di condizione difficilmente riconducibili a categorie predefinite.
Da ciò la mia opinione che sono "standardizzabili" le risorse che i servizi
utilizzano per "garantire" livelli uniformi di prestazione e non i bisogni delle
persone con disabilità. Un'ulteriore criticità è il percorso di accesso alla
RSD, dove la valutazione del bisogno della persona con disabilità è fatta a
"valle" e non a "monte" dell'accesso al servizio. Questa è la maggior criticità
del sistema RSD così come di altri servizi per persone con disabilità, ossia la
valutazione del sostegno erogato alla persona con disabilità viene fatta in
funzione del servizio erogato indipendentemente dal bisogno della persona, ciò
conduce indirettamente alla "standardizzazione" dei bisogni della persona con
disabilità. Insomma molta attenzione è stata posta in questi anni nella
valutazione della prestazione a garanzia della "qualità" del servizio erogato
più che a sostegno della "bontà" del progetto di vita e di cure delle persone
con disabilità. A mio parere i due approcci non sono in contrasto o
competizione, non si escludono ma si completano ed in tal senso occorre lavorare
per il futuro.
Ho colto l'occasione che mi è stata offerta in questo spazio di discussione per una riflessione più generale di contenuto del servizio RSD rispetto ad una trattazione più tecnica e articolata (che rimando ad altra occasione) per ribadire una volta di più che la "bontà" dei servizi la fanno prima di tutto le persone che vi operano (formate, competenti e motivate) con il sostegno di "buone" organizzazioni; la buona volontà ed i buoni propositi da soli non portano a buoni servizi, così come norme e organizzazioni costruite solo su "categorie" ideali, non sottoposte alla verifica dei bisogni reali, sono sterili e inutili. Quest'ultima affermazione mi da lo spunto per sottolineare una volta di più che i "bisogni reali" delle persone con disabilità sono oggi poco conosciuti ed in continua evoluzione, per cui si rende necessario quanto prima di colmare questo "gap" di conoscenza, se non vogliano continuare a decidere e discutere di e per persone con disabilità "ideali" a cui proporre servizi reali (…)». In questo contributo vi sono elementi che concorrono a dimostrare quanto sia superficiale affrontare questi temi solo sulla spinta di posizioni ideologiche, senza tener conto ed approfondire le reali necessità di ogni persona, con una valutazione del bisogno fatta – appunto – "a monte" dell'accesso a un servizio. Come ha scritto Marco Bollani, la RSD è davvero un servizio da ripensare, e prima lo si fa meglio è. Ripensarlo però non vuol dire "rottamarlo", metterlo al bando, negarne la necessità, l'utilità. Semmai il contrario.
*Presidente Anffas Onlus Milano e Consigliere Nazionale Anffas Onlus
11 aprile 2011